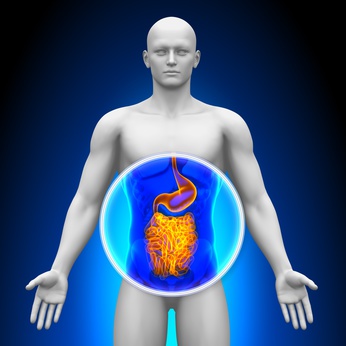Era il 1973 quanto Katie Relf, una donna di colore dell’Alabama, povera e analfabeta, firmò con una X un documento in cui autorizzava, senza saperlo, la sterilizzazione chirurgica delle sue due figlie minorenni e mentalmente disabili: Mary Alice, di quattordici anni e Minnie, di dodici. Katie pensava di aver approvatol’inserimento della spirale intrauterina per le bambine che invece vennero private, senza il consenso informato di nessuno, dei loro diritti riproduttivi. L’anno seguente, il Southern Poverty Law Center, un’organizzazione nata appena tre anni prima per aiutare gli afroamericani che vivevano in condizioni di estremo disagio sociale, squarciò il velo rivelando che una grandissima quantità di persone indigenti era stata sterilizzata seguendo le direttive di un programma federale.

Quando si parla di eugenetica, si pensa subito al nazismo. L’idea che la manipolazione genetica e la selezione delle nascite possa portare al miglioramento della società era molto diffusa agli inizi del secolo scorso, con il beneplacito di medici, legislatori e intellettuali. Quest’idea si basava su un principio molto semplice, ovvero che la società andasse ripulita da tutti quegli individui che avrebbero potuto ostacolare la perfezione della razza e il progresso – disabili, persone affette da malattie mentali o appartenenti a razze considerate inferiori, omosessuali. Una soluzione per perseguire questo obiettivo, prima di passare all’eliminazione fisica con l’Aktion T4,sotto il regime nazista, fu la loro sterilizzazione. Le Erbgesundheitsgerichten, le “Corti per la salute ereditaria” istituite nel 1933, erano gli organi nazisti preposti al controllo delle nascite che fino alla caduta del regime sterilizzarono fino a 400.000 persone.

In realtà, però, i prodromi dell’eugenetica non nascono da dittature e regimi oppressivi, ma dai democraticissimi Stati Uniti, dove istituzioni private come la Rockfeller Foundation finanziavano studi e ricerche a cui partecipò anche Josef Mengele, passato alla storia come il “medico della morte” di Auschwitz. Questi studi venivano condotti principalmente nelle prigioni e presso il New York Bureau of Industries and Immigration sugli immigrati ebrei e italiani, tra le vittime di sterilizzazione coatta più colpite. Far sì che queste popolazioni non proliferassero contaminando quella americana era considerato un dovere morale. Il delirio “progressista” dell’eugenetica non riusciva a individuare una connessione tra il disagio sociale degli immigrati e le loro condizioni di vita disumane, ma trovava più che ovvio pensare che criminalità, malattie e analfabetismo fossero conseguenze dirette dell’appartenenza a una razza inferiore, come erano viste quella italiana, ebrea o latina. Poiché fermare l’immigrazione sembrava impossibile, l’unica soluzione a cui si pensò fu quella di cercare di bloccare la riproduzione dei nuovi arrivati.


Il governo non solo approvò i programmi di sterilizzazione forzata, ma li portò avanti fino agli anni ’70. Si stima che dagli anni ’30 fino alla conclusione del piano, negli Stati Uniti siano state sterilizzate 65.000 persone. Queste sterilizzazioni avvenivano spesso coattivamente su individui che non avevano facoltà di scelta, ad esempio nei manicomi, oppure con l’inganno, come nel caso delle due sorelline Mary Alice e Minnie. I “pazienti” venivano spesso convinti dai medici di avere malattie incurabili, oppure alle donne che volevano abortire veniva praticata l’isterectomia, la rimozione dell’utero, senza un vero motivo medico. In altri casi, compagnie assicurative o programmi di welfarestatali si spingevano verso zone rurali, soprattutto negli Stati del Sud, e proponevano la sterilizzazione tubarica o la vasectomia come soluzioni contraccettive gratuite e veloci, senza che le vittime conoscessero realmente le conseguenze di tali interventi. Inizialmente i programmi di sterilizzazione furono pensati come tentativi di fermare un “morbo” – che fossero vere e proprie malattie mentali o soltanto condizioni di disagio sociale – ma verso gli anni ’60 si trasformarono in un vero e proprio modo per controllare le donne, soprattutto quelle di colore. Bastava infatti molto poco per bollare una ragazza sessualmente promiscua come “minorata mentale” e poter procedere in modo del tutto legale alla sua sterilizzazione.

Da un lato, la sterilizzazione forzata, secondo l’articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, costituisce un crimine contro l’umanità, perché viola i diritti fondamentali alla riproduzione e alla salute; dall’altro, è un crimine di genere, perché sebbene sia stata spesso imposta sia a uomini che a donne, ha colpito più duramente quest’ultime, soprattutto quelle facenti parte di una minoranza (afroamericane, latine o native). Quasi tutte le vittime di sterilizzazione forzata erano in qualche modo già sottoposte al controllo dello Stato, tramite, ad esempio, l’edilizia popolare, le indennità di disoccupazione, gli istituti per la salute mentale o le istituzioni carcerarie. Il governo, per convincere le donne a firmare i documenti di autorizzazione alla sterilizzazione, faceva presa sulla loro coscienza puntando su temi già molto delicati, come la povertà o l’inadeguatezza al ruolo di madri. Agendo su soggetti già fragili, le conseguenze della sterilizzazione forzata erano e sono tuttora devastanti, dalla Sindrome Post Traumatica da Stress alla perdita di identità. Non da ultimo, il fatto che nella maggior parte dei casi queste persone provenissero da gruppi di minoranza ha aggiunto ai disagi della maternità privata anche l’impossibilità di identificarsi in una comunità. L’auto-definizione, secondo l’autrice Dorothy Roberts, è un fattore fondamentale per l’identità delle donne afroamericane, perché lo Stato per lungo tempo gliene ha negata una. Le donne di colore si sono autocostruite un’identità sulla base del loro genere e della loro etnia, rivendicando il loro ruolo di minoranza tramite una comunità autoprodotta. Essere sterilizzata in una comunità simile ti rende ancora più minoranza di quanto non fossi prima: vivi la tua sterilizzazione non solo come “punizione” per il fatto che sei una donna, ma soprattutto perché sei una donna nera. La tua integrità corporea è venuta meno, così come la possibilità di coesione al gruppo delle “madri”, che diventava cruciale in un contesto come quello statunitense degli anni ’50 o ‘60, dove gran parte dell’identità delle donne di colore si affermava proprio attraverso la maternità.

Il corpo delle donne è stato più volte, in particolare negli Stati Uniti, terreno di una battaglia politica dove l’autorità è intervenuta per imporre le proprie idee conservatrici e retrograde. Basti pensare tutt’oggi alle dure regolamentazioni sull’aborto, all’ossessione del sistema educativo per il tema dell’astinenza, che più che educare umilia gli adolescenti sessualmente attivi, oppure alla difficoltà, soprattutto per le donne di colore, di beneficiare di cure ginecologiche e ostetriche adeguate, come dimostra il fatto che il tasso di mortalità durante il parto di quest’ultime sia tre volte superiorea quello delle donne bianche. Lo scorso ottobre, l’amministrazione Trump ha eliminato un mandato dell’Obamacare che garantiva la copertura contraccettiva gratuita da parte delle aziende per le impiegate di sesso femminile, rendendo possibile il rifiuto di questa protezione sulla base di “obiezionimorali o religiose”. Ma questa è una triste tradizione che va avanti fin dalla fine dell’Ottocento, quando si passò dalla massiccia sterilizzazione degli uomini nelle carceri e nei manicomi a quella delle donne comuni, che avevano la sola sfortuna di essere nate povere e nere. Il corpo libero delle donne era visto come una minaccia imprevedibile e irrazionale, come vuole lo stereotipo della donna indomabile e “isterica”. Le intrusioni dello Stato non riguardano le donne in quanto soggetti, ma in quanto corpi che non possono liberamente autodeterminarsi, e di cui ci si arroga il diritto di controllare, delimitare e imprigionare. Il primo bersaglio da colpire è la sessualità: rendere la contraccezione e l’aborto procedure impossibili e costose, inculcare l’idea che ogni rapporto sessuale sia il male, mutilare la donna privandola dei suoi organi riproduttivi. Lo Stato si pone come garante della salute pubblica e individuale ricorrendo a queste misure per nascondere dietro la scusa della sua funzione pedagogica, una ben più radicata funzione coercitiva e autoritaria.
Il problema della sterilizzazione forzata non è parte esclusiva del passato americano, purtroppo è ancora ben presente. Le migliaia di vittime, sottoposte alla procedura negli anni ’60, ’70 e ’80, magari quando erano ancora bambine, portano ancora addosso i segni fisici e psicologici di questa violenza, senza che nessuno abbia mai chiesto loro scusa o le abbia risarcite in qualche modo. E, come se non bastasse, esistono casi in cui la sterilizzazione forzata è stata praticata in tempi recenti.

Nonostante in molti degli Stati sia stata dichiarata illegale, la procedura viene tuttora eseguita, soprattutto nei confronti delle donne afroamericane. Si stima che nel 1990, a vent’anni dalla fine del programma federale, il 24% delle donne di colore sia stata sterilizzata in modo coatto. Molto spesso queste operazioni venivano eseguite dopo un aborto in giovane età in contesti sociali difficili, come racconta Maria in una puntata del podcast “The Heart”. Maria, una ragazza di origini portoricane rimasta incinta a 15 anni, andò in una clinica per abortire e si risvegliò dall’operazione senza utero, dopo che il personale medico le aveva detto: “Questo è quello che ottieni quando fai sesso così presto”. Ma il caso più grave, per la sua diffusione e sistematicità, è quello delle prigioni. Nelle carceri californiane, tra il 2006 e il 2010, circa 150 donne sono state sterilizzate tramite legatura delle tube su volontà dei medici e dei dipendenti del carcere grazie ai fondi erogati dallo Stato della California, nonostante il Titolo 42 delle leggi federali dedicato alla sanità pubblica proibisca esplicitamente la sterilizzazione di “qualsiasi individuo incapace o internato”. I dipendenti delle carceri, incalzati dalla redazione del Center for Investigative Reporting, a loro difesa dissero che stavano semplicemente fornendo un importante strumento per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Uno strumento che disumanizza le donne considerate inadatte al miglioramento della società. Il caso delle prigioni californiane dimostra come ancora oggi il germe dell’eugenetica e del progresso a tutti i costi sia ben radicato in una società come quella americana che eppure si professa civile e democratica.

È vero che la maggior parte degli Stati ha cancellato le leggi sulla sterilizzazione forzata, ma in alcuni, come ad esempio lo Stato di Washington, esistono ancora. Nel 2011, la North Carolina ha avviato le procedure per risarcire le vittime di sterilizzazione forzata costituendo l’NC Justice for Sterilization Victims Foundation e stanziando, a partire da giugno 2015, dieci milioni di dollari da distribuire a 7.600 persone. Ma è l’unico Stato americano ad aver pensato a un risarcimento – per quanto possa contare. Si deve fare ancora molto per dare riconoscimento e dignità alla storia delle sterilizzazioni forzate negli Stati Uniti. Le istituzioni, a parte le scuse pubbliche e i tentativi di risarcimento, non sembrano far nulla per creare sensibilizzazione su questa pagina importante della storia recente americana. Gruppi di studiosi e ricercatori, come quello guidato da alcune scholars dell’Università del Michigan e dell’Illinois, stanno conducendo studi per cercare di definire tutti i numeri del fenomeno e, soprattutto, invitare le superstiti a far sentire la propria voce. Al momento, sono gli unici testimoni di questa storia. L’impressione è che gli Stati Uniti abbiano grosse difficoltà non tanto ad assumersi la responsabilità, ma anche solo ad ammettere di aver violato sistematicamente i diritti umani per più di cinquant’anni. Nel 2014, un anno dopo lo scandalo delle carceri, la California ha vietato la sterilizzazione nei penitenziari a eccezione di casi che compromettano la salute pubblica. Si stima che dal 1909 al 1963, nella sola California siano state sterilizzate 20.000 persone. Nessuna di queste è stata mai risarcita